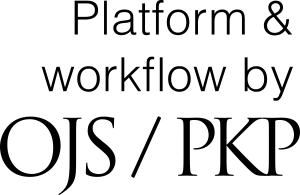Richiesta di contributi n. 199 (2025)
Abitare la transizione. Per una Pedagogia del lavoro all’altezza della sfida algoritmica
L’intelligenza artificiale (IA) ha cessato di essere un’ipotesi futuribile per diventare un paradigma tecno-economico che sta innescando una metamorfosi radicale del lavoro e della società. La sua capacità di automatizzare non solo compiti manuali, ma anche attività cognitive complesse, sta ridisegnando le architetture professionali, generando una polarizzazione del mercato del lavoro e rendendo potenzialmente obsolete intere categorie di competenze. Questo scenario, definito da molti come la “quarta rivoluzione industriale” (Schwab, 2016), si differenzia dalle precedenti transizioni. Le trasformazioni tecnologiche del presente potrebbero non limitarsi a supportare l’attività umana, ma a sostituirla progressivamente proprio nella sua funzione più caratteristica: l’elaborazione simbolica, la capacità di interpretare il reale, di attribuire significato e di produrre contenuti automatici. Per la prima volta nella storia, il lavoratore rischia di essere estromesso dall’atto stesso di lavorare, ridotto a supervisore di un processo che si svolge senza il suo coinvolgimento attivo. Non siamo al cospetto di un mero problema tecnologico o economico, ma a una profonda sfida antropologica e culturale che impone una riconsiderazione dei fini e dei mezzi dell’educazione, sollecitando la pedagogia a un dialogo serrato con le nuove frontiere tecnologiche.
L’automazione di compiti cognitivi e la riconfigurazione dei saperi professionali rischiano di essere interpretati attraverso una lente puramente economica, riducendo la formazione a un dispositivo di adattamento della “risorsa umana”. Questo approccio, sebbene pervasivo, è pedagogicamente insostenibile, poiché ignora la dimensione esistenziale, identitaria e politica del lavoro, trascurando lo sviluppo di quelle “capacità umane” fondamentali per una vita fiorente (Nussbaum, 2011).
In questo scenario, la pedagogia del lavoro assume un ruolo cruciale. La sua vocazione non è inseguire la contingenza tecnologica, ma affermare un paradigma formativo che ponga al centro la persona, promuovendone l’agency e la capacità di costruire un percorso professionale dotato di significato. Si tratta di interrogarsi su come la formazione possa diventare uno spazio di emancipazione e non di addestramento; un luogo dove si impara a collaborare criticamente con la tecnologia, non a subirla.
Questo numero monografico si propone di raccogliere contributi di ricerca e di riflessione teoretica che, adottando esplicitamente la prospettiva della pedagogia del lavoro, indaghino le trasformazioni in atto. L’obiettivo è duplice: da un lato, analizzare criticamente le retoriche e le pratiche formative che accompagnano l’introduzione dell’IA; dall'altro, delineare modelli pedagogici in grado di sostenere individui e organizzazioni nella costruzione di un futuro del lavoro equo e umanamente sostenibile, preservando il “sapore del mestiere” (Sennett, 2008) anche nei contesti algoritmici.
Aree tematiche da approfondire
1. La Scuola e la costruzione delle basi per l’agibilità professionale
-
Dalla competenza all’agency: come può il sistema scolastico superare un approccio contenutistico per coltivare l’agency professionale? Quali dispositivi didattici possono promuovere negli studenti le metacompetenze essenziali per affrontare la complessità e l'incertezza del futuro, come l’auto-orientamento, la flessibilità cognitiva e l’imparare a imparare?
-
L'orientamento come pratica di progettazione esistenziale: come trasformare l’orientamento in un percorso longitudinale che aiuti gli studenti a “costruire la propria vita” personale e professionale attraverso la narrazione di sé? Come usare criticamente gli strumenti di IA per ampliare gli orizzonti, anziché restringerli sulla base di profili predittivi?
-
I PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento) come laboratorio critico: Come possono le esperienze in contesti lavorativi diventare un’occasione per “pensare criticamente” il lavoro? Quali modelli di tutoraggio e quali metodologie possono trasformare lo studente in un "professionista riflessivo" in azione, capace di decodificare le nuove forme di organizzazione e le implicazioni etiche del lavoro algoritmico?
2. Formazione continua e sviluppo umano nelle organizzazioni aumentate
-
Oltre l’upskilling (miglioramento e aggiornamento delle competenze):sviluppo professionale e valore delle competenze umane. Si cercano contributi che analizzino criticamente l’ideologia dell’aggiornamento perpetuo e propongano modelli di formazione continua centrati sullo sviluppo integrale della persona-che-lavora. Quali metodologie formative possono supportare i lavoratori nel dare senso alle transizioni, nel valorizzare il proprio capitale di esperienze e nel riprogettare la propria identità professionale?
-
La formazione delle soft skills tra sviluppo umano e strumentalizzazione. Come progettare interventi formativi che promuovano autenticamente le competenze umane (empatia, intuizione, relazione, giudizio critico, giudizio etico,)? Qual è il confine etico tra lo sviluppo di queste abilità per il benessere della persona e la loro strumentalizzazione da parte di un “capitalismo emozionale”?
-
L'IA come dispositivo formativo: potenzialità pedagogiche e rischi di controllo. Analisi approfondite sull’uso di piattaforme adattive e learning analytics. Quali sono i rischi di un capitalismo della sorveglianza applicato alla formazione, che trasforma l’apprendimento in un dato da monitorare? Si incoraggiano studi di caso su pratiche che utilizzano l'IA per favorire l'apprendimento collaborativo e l'autonomia del discente.
3. Politiche, etica e cittadinanza: la dimensione macro della pedagogia del lavoro
-
Il diritto alla formazione come pilastro della cittadinanza attiva: come può essere garantito il diritto soggettivo alla formazione permanente? Si sollecitano analisi di politiche attive del lavoro che interpretino la formazione come un investimento per la coesione sociale e l'espansione delle libertà individuali.
-
Giustizia formativa e de-biasing algoritmico (rimozione dei pregiudizi prodotti dall’IA): l’uso dell’IA nei processi di HR- Human Resources (risorse umane) solleva cruciali questioni di equità. Si cercano contributi che, partendo dall’analisi dei bias (pregiudizi), propongano linee guida per la progettazione e l'implementazione di sistemi di gestione delle risorse umane, etici, trasparenti e giusti.
-
Nuove forme di cittadinanza organizzativa: l’IA sta ridisegnando le relazioni di potere e la collaborazione. Quale ruolo per la pedagogia del lavoro nel promuovere una “cittadinanza organizzativa” attiva? Come formare manager e lavoratori a partecipare alla co-progettazione di organizzazioni che apprendono più umane e democratiche?
Tipologie di Contributi
Al fine di favorire un dialogo ricco e plurale, la rivista accoglierà diverse tipologie di contributi scientifici. Sono particolarmente incoraggiate le seguenti forme:
Saggi di riflessione teoretica: contributi di natura teorica, epistemologica o di rassegna critica della letteratura nazionale e internazionale, che approfondiscano i costrutti chiave della pedagogia del lavoro alla luce della sfida posta dall’intelligenza artificiale.
Contributi di ricerca empirica: presentazione di risultati di ricerche originali, basate su metodologie qualitative (studi di caso, etnografie, ricerca-azione, approcci narrativi), quantitative (sondaggi, analisi statistiche) o miste, condotte in contesti scolastici, universitari, aziendali o territoriali.
Analisi di pratiche e studi di caso: descrizione e analisi critica di esperienze formative, progetti innovativi o dispositivi pedagogici implementati, con una chiara esplicitazione del quadro teorico di riferimento, della metodologia di analisi e delle implicazioni per la pratica e la ricerca futura.
Contributi di taglio metodologico: riflessioni sulla progettazione, l’implementazione e la valutazione di interventi formativi in contesti complessi, con un focus sulle sfide metodologiche introdotte dall'integrazione dell'IA nei processi di apprendimento e sviluppo professionale.
Scadenze :
· invio abstract di circa 600 (seicento) caratteri spazi inclusi, con le relative parole chiave, in italiano (o nella lingua di origine) e in inglese (con nome e cognome, ente/università di afferenza, indirizzo email istituzionale) entro il 20 agosto 2025 a: donatella.lombello@unipd.it ; carla.xodo@unipd.it ; pampaedia.aspei@gmail.com ;
· invio contributi in forma di saggio di almeno 25.000 (venticinquemila) caratteri, spazi inclusi, entro il 20 settembre 2025 a: donatella.lombello@unipd.it ; carla.xodo@unipd.it ; pampaedia.aspei@gmail.com .
I contributi saranno valutati con un processo di peer review in modalità double blind : scadenza per eventuali modifiche richieste dai referee : 05 novembre 2025.
Data di pubblicazione: 31 dicembre 2025 .
LINK ALLE NORME EDITORIALI download
NUOVA STRUTTURA DELLA RIVISTA
Col numero 198/2025 la nostra rivista ha assunto la seguente struttura:
-
Sezione-Articoli in risposta alla “call” (referaggio a doppio cieco)
-
Sezione- Articoli “liberi” su tematiche pedagogico-didattico-educative d’attualità o di particolare rilievo, riguardanti ricerche storico-pedagogiche, anche in chiave comparativa, la Letteratura per l’infanzia, la lettura (referaggio a doppio cieco)
-
Informazioni/contributi di Convegni-Congressi-Iniziative culturali
-
Sezione Recensioni
Per i contributi relativi alla Sezione “articoli liberi” valgono le stesse regole e scadenze relative a quelli della “call”