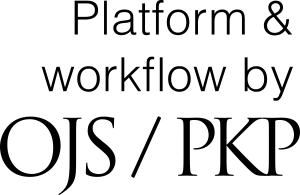CALL FOR PAPER 1/2025
Ricerche e riflessioni della Pedagogia Speciale sull'Intelligenza Artificiale
Curatrici/ore. Serenella Besio (Università degli Studi di Bergamo), Stefania Pinnelli (Università degli Studi del Salento), Maurizio Sibilio (Università degli Studi di Salerno)
Il dibattito mediatico sull'impatto dell'intelligenza artificiale nei diversi ambiti della vita è sempre più acceso, ma spesso privo di quelle analisi scientifiche necessarie per descrivere con rigore, senza semplificazioni o stereotipi, il reale significato e le conseguenze di questa rivoluzione tecnologica. Ne emerge una narrazione polarizzata, in cui le posizioni oscillano tra visioni catastrofiche (apocalittiche) e un'adesione incondizionata (integrata), riproponendo in forme nuove percezioni contrastanti e categorie di pensiero di echiana memoria.
Infatti, ancora oggi, a oltre mezzo secolo di distanza, persiste un duplice rischio legato a interpretazioni opposte dell’intelligenza artificiale: da un lato, visioni catastrofiche che ne enfatizzano le minacce; dall’altro, approcci funzionalisti che ne esaltano quasi esclusivamente i benefici in termini di efficienza ed economia nei settori in cui viene applicata.
In questo contesto, la ricerca scientifica dovrebbe avere il compito di ridurre le contrapposizioni, riportando l’attenzione su come garantire il primato dell’essere umano sugli strumenti e sugli ambienti tecnologici che crea. Ciò implica dimostrare che le tecnologie non potranno mai trasformarsi in protesi cognitive, ma resteranno esclusivamente strumenti di supporto all’azione umana.
Una riflessione scientifica e culturale in questa direzione permetterebbe di far evolvere l’umanesimo digitale, evocato ad esempio da Stefano Rodotà ma rintracciabile anche in Carlo Sini, Massimo Adinolfi o Gino Roncaglia, verso un umanesimo che agisce consapevolmente sul digitale, riaffermando il principio che responsabilità e decisione restano prerogative esclusivamente umane.
In questa prospettiva, l’azione umana, non limitandosi alle sole esperienze e informazioni possedute, si sviluppa in uno spazio di libertà imprescindibile. Questa caratteristica dell’azione umana si manifesta soprattutto in situazioni estreme o di rischio, attraverso modalità creative, solidali e talvolta radicali, che non derivano da calcoli o previsioni, ma si radicano nella natura dinamica e mutevole dei valori e dei principi che costituiscono l’architettura culturale di una comunità.
Anche in questo contesto, la comunità pedagogica rappresenta un punto di riferimento essenziale, in grado di orientare la riflessione scientifica su più fronti: dalle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale per tutelare i diritti inalienabili della persona, al potenziamento dei processi educativi inclusivi e alla valorizzazione delle potenzialità umane in un’ottica di equitable education for all. Al tempo stesso, la comunità pedagogica può indicare la direzione, nella scuola e in tutti gli ambienti educativi e formativi, per promuovere competenze critiche e approccio consapevole all’uso dell’intelligenza artificiale, valorizzando il pensiero laterale e gli spazi non lineari della cognizione umana.
Sulla base di questa premessa, dunque, risulta chiaro come la comunità pedagogica nazionale e internazionale, e la pedagogia speciale in particolare, si trovino di fronte all’eccezionale occasione di approfondire riflessioni innovative e modelli di intervento coerenti, su ogni piano coinvolto da questa trasformazione epocale, con particolare riguardo alle aree della cultura, della cura, e dell’educazione.
Fra i vari settori chiamati direttamente in causa ci sono senz’altro e fra gli altri: la formazione universitaria e in servizio, affinché studenti, insegnanti, operatori, pedagogisti possano affrontare le sfide attese nel modo più consapevole possibile, introducendo e monitorando gli elementi di novità implicati; la didattica speciale e quella inclusiva, che vedranno potenziate le modalità di intervento e di supporto nelle varie discipline e nelle programmazioni individuali e di classe; lo sviluppo e l’utilizzo di strumenti tecnologici e tecnologie assistive per le persone disabili e fragili, al fine di accrescerne le possibilità di autonomia e indipendenza in ogni ambito della vita; la qualità della ricerca sperimentale e teoretica, che potrà avvalersi di modalità originali di indagine e di metodologie potenziate per l’analisi dei dati; la divulgazione scientifica, per dare risposte a educatori, genitori, decisori politici, interessati a conoscere come questa nuova frontiera tecnologica possa agire rispetto ai risultati di apprendimento, alle opportunità di sviluppo, di autonomia e partecipazione ma anche in relazione alle abilità e capacità dell’individuo.
Ancora più interessanti sono poi le domande che tali innovazioni sollecitano, se si focalizza lo sguardo su tematiche più circoscritte – l’inclusione e la disabilità, ad esempio – ma anche se ci si concentra su questioni esplicitamente teoretiche, volte ad esplorare categorie, valori, dimensioni ontologiche o etiche.
Dalla Strategia Italiana per l’Intelligenza Artificiale (Ministero dello sviluppo economico, 2019), l’Italia si è dotata di un Programma Strategico 2022-2024 per lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale, fortemente centrato sulla prospettiva di sviluppo infrastrutturale ed economico, nel quale la formazione è considerata solo come strumento di incremento di competenze tecnologiche.
Sono invece, come anticipato, molteplici i quesiti che interpellano la nostra società. Tra questi: Quali sono oggi i compiti delle istituzioni responsabili della formazione, dalla scuola all’università, anche in considerazione della recente trasformazione dei sistemi di fact-checking e il controverso passaggio a soluzioni basate sulle community notes da parte delle principali piattaforme social?
Quali sono le opportunità, quali i pericoli, quali i compiti pedagogici?
Le popolazioni a rischio sono soprattutto quelle più fragili, con basso livello di istruzione, gli adolescenti, le persone con disabilità e gli anziani, che possono facilmente cadere vittime di raggiro, inganno, violazione.
Contraddittoriamente, proprio per queste popolazioni, le tecnologie di ultima generazione e l’Intelligenza Artificiale costituiscono una risorsa impensata finora, potenzialmente rivoluzionaria, per migliorare la qualità della loro vita.
Ebbene, il primo numero del 2025 dell’Italian Journal on special Education for Inclusion sollecita studiosi/e e ricercatori/ici nazionali e internazionali a presentare le proprie riflessioni e le ricerche in atto, di carattere sperimentale o teoretico su tali tematiche. Lo scopo è quello di iniziare a tracciare una road map di orientamento della ricerca in pedagogia speciale in questo ambito, valorizzando gli studi in ottica interdisciplinare e in relazione ad ogni età e ad ogni contesto di vita.
Per tale ragione sono attese e accolte in questo numero riflessioni teoriche, revisioni sistematiche, meta-analisi, ricerche qualitative e quantitative, buone prassi, esperienze sul campo e altri contributi che possano esplorare e offrire possibili ambiti di analisi.
I contributi, in forma di saggio della lunghezza di 30.000 caratteri (spazi compresi), dovranno pervenire alla redazione della rivista entro il 31 marzo 2025 tramite il sito
https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/sipes .
I contributi, pena la loro non accettazione, all’atto del caricamento dovranno essere completi di:
- titolo in italiano e in inglese
- abstract in inglese
- parole chiave (min 3, max 5, in inglese)
- nome e cognome dell’autore/ice o degli/delle autori/ici
- ruolo, affiliazione, mail, dell’autore/ice o di ciascun autore/ice in inglese
- (in caso di più autori/ici, indicazione del nome cognome e mail del Corresponding Author)
I contributi saranno valutati con un processo di peer reviewing in modalità double blind.
Scadenze:
Sottomissione proposte (https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/sipes): 31 marzo 2025
Pubblicazione: giugno 2025