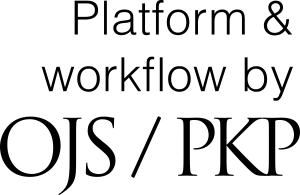Perché non fuoro a me gli occhi dispenti di Guido Cavalcanti
Abstract
Come già nell’attacco di Li mie’ foll’occhi (V), dove però non si va oltre l’accusa di sconsiderata temerarietà, l’istanza di rievocare l’evento supremo della vista della donna trova sfogo in una desolata imprecazione contro i proprii occhi, primi responsabili della genesi di amore (vv. 1-2). L’esplicita presentazione della passione in termini di avvento di una «veduta forma» nella mente (cfr. XXVIIb, 21; per una descrizione analitica del processo di generazione della species mentale della donna, anche se in termini eccezionalmente ‘positivi’, si veda XXVI, 5-12) implica quindi l’immediata definizione di uno spazio interiore, dove risuona la voce minacciosa del phantasma della stessa donna, cui risponde quella dell’anima sgomenta che ne implora la pietà (vv. 3-4). Emblematica trasfigurazione – e per Guido unica possibile realizzazione – del dialogo cortese nella dimensione alienata e autoreferenziale della psiche.
I commentatori, da Contini in poi, sono concordi nel protrarre la preghiera dell’anima fino alla conclusione del sonetto, includendovi l’ulteriore e misteriosa voce finale (vv. 12-14). Si tratta tuttavia di una lettura che comporta non solo un «vistoso effetto di tensione tra metro e sintassi» (CASSATA), ma anche una certa difficoltà nelle relazioni logico-temporali degli eventi rappresentati.